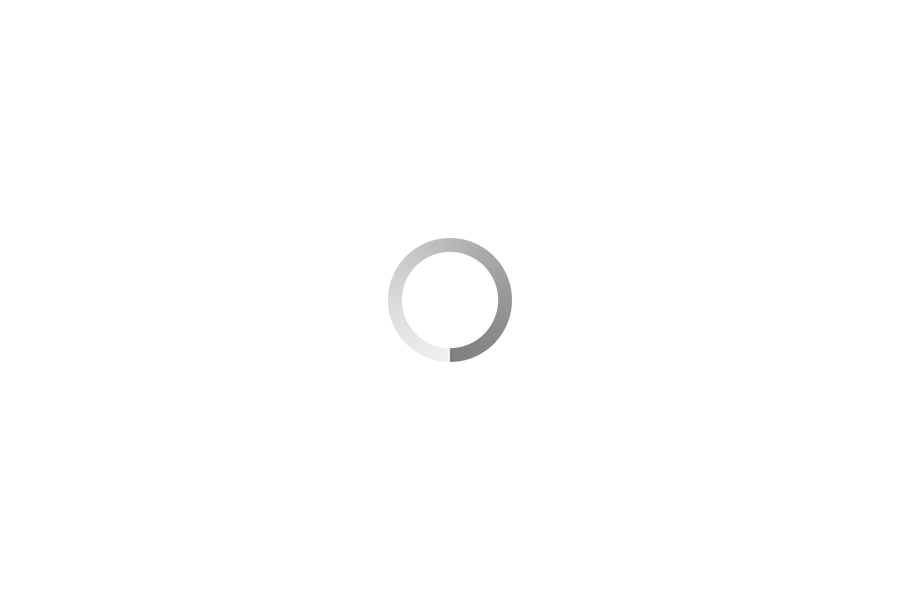Expert Insights: Fabio Novembre
Fabio Novembre nasce a Lecce nel 1966. Nel 1984 si trasferisce a Milano dove si laurea in Architettura al Politecnico. Nel 1992 si sposta a New York dove frequenta un corso di regia cinematografica presso la New York University. Durante questo soggiorno americano incontra Anna Molinari che nel 1994 gli commissiona il suo primo lavoro di architettura d’interni: il negozio “Anna Molinari Blumarine” ad Hong Kong. Nello stesso anno torna a Milano e apre il suo studio. Progetta architettura e interni per i più importanti brand internazionali. Collabora con le più grandi aziende italiane di design come Driade, Cappellini, Venini, Meritalia e Kartell, sviluppando inoltre showroom, boutique e interni per realtà internazionali come Lavazza, Blumarine e Stuart Weitzman. Ci può raccontare come è iniziata la sua carriera? Dopo la laurea in Architettura a Milano mi sono trasferito a New York per studiare regia cinematografica. Ma la mia fortuna newyorkese è stata quella di incontrare Anna Molinari. Al tempo vivevo nel Lower East Side e frequentavo amicizie assolutamente trasversali e stimolanti, dal regista Jim Jarmusch alla gallerista Holly Solomon (per la quale lavoravo come tuttofare). Anna non poteva certo giudicarmi dall’esperienza, dato che non avevo mai fatto pratica in uno studio di architettura, ma il potenziale creativo era respirabile già dall’environment che mi ero creato. Fu così che con una buona dose di incoscienza, sua e mia, fui incaricato di disegnare il primo negozio Blumarine a Hong Kong. Il resto è noto… Durante l’evento I’M Alumni Global Reunion di Istituto Marangoni tenutosi il 18 maggio 2017, ha affermato di non riconoscersi nella sola definizione di “architetto”. Quali sono gli altri “volti” di Fabio Novembre? Quello che faccio appartiene alla categoria dei mestieri difficili da spiegare ai propri genitori. Quando lasciai casa dei miei per venire a studiare a Milano, era facile tradurre la mia condizione in «iscritto al Politecnico di Milano presso la Facoltà di Architettura», anche se poi avrei capito che fare l’architetto non sarebbe stato un mestiere, bensì un approccio alla vita. Devo ammettere che era difficile spiegare a mia madre perché disegnavo un tavolo con centosettantuno gambe o il mio amico Maarten Baas bruciava vecchie sedie prima di usarle. Far coincidere la forma con la funzione era un ottimo alibi finché sono stati chiari i termini della questione, ma chi di noi è oggi in grado di giustificare la maggior parte degli oggetti che ci circondano? Quale parte preferisce del suo lavoro? Da sempre ripeto che non amo gli specialismi. Non mi sento un professionista, bensì un dilettante. Il dilettante, per la natura stessa del termine, è colui che prova diletto nel fare le cose. Inoltre la traduzione del termine sia in inglese che in francese è amateur. Credo sia evidente a tutti che è meglio provare diletto e amare che tradurre la passione in «professionismo/specialismo». Dalla sua esperienza con molti grandi brand del mondo del design, quali sono i suoi consigli per mantenere un rapporto di valore ed equilibrato con l’azienda-committente? Non credo ci sia una regola, oggi vale un po' tutto. Un dato che però trovo interessante è che oggi, nell'immaginario collettivo, la figura del progettista tende a prevalere su quella dell'azienda, sottolineando una profonda crisi identitaria dell'imprenditoria. Nei suoi progetti di design, quanto spazio è stato dato alla sua creatività e libertà espressiva? Questo è un punto che mi è chiaro da quando ho aperto il mio studio: il mio lavoro è una forma di sperimentazione, non la semplice erogazione di un servizio. Con lo spazio come ambito espressivo. Più che dare risposte, io amo far sorgere nuove domande. E sia chiaro: al massimo di libertà deve sempre corrispondere il massimo di responsabilità. Oggi i giovani devono affrontare molte difficoltà per riuscire a dimostrare il proprio talento. Quali sono i suoi consigli per affrontare al meglio il mondo del lavoro mantenendo viva la propria passione? Io credo che la vita sia soprattutto un problema di allineamento delle priorità, e forse fare design è proprio questo: stabilire le proprie. Ma un buon designer deve essere prima di tutto una buona persona, in maniera che la sua voglia di trasformazione non evolva in forme di prevaricazione. Direi che sentirci tutti designer del proprio destino sarebbe già un punto di partenza responsabile. Crede che la partecipazione a concorsi internazionali rappresenti un’opportunità di valore in tal senso? La diffusione capillare della rete aiuta a far conoscere il proprio lavoro. Soltanto concorsi con una buona audience sono realmente un’opportunità. In ogni caso, a meno che non siano con un fee di partecipazione, qualsiasi occasione può rivelarsi quella giusta. Nel suo studio, quali sono le skills e i valori che ricercate maggiormente? Poliedricità, competenza ma soprattutto curiosità. I miei progetti si alimentano delle influenze più disparate e i miei collaboratori devono essere in grado di carpirle. Quali sono secondo lei gli aspetti su cui le scuole di design dovrebbero oggi puntare di più, a livello formativo, per preparare nuove risorse ad entrare nel mercato del lavoro? Ho sempre pensato che il ruolo di una scuola sia quello di insegnare un metodo. La formazione deve essere mirata a far fronte a problemi di cui nella maggior parte dei casi non si conoscono le soluzioni. Il nozionismo quanto il tecnicismo hanno valore tattico. La versatilità è strategica.
Sei interessato a uno o più corsi?